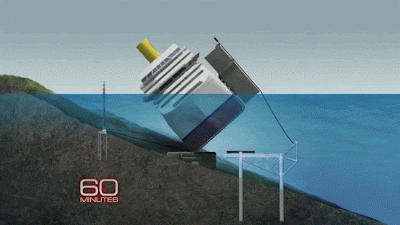E’ un Verdi inedito quello che compare attraverso le lettere amorevolmente raccolte da Eduardo Rescigno e stampate da Einaudi in un bel volumone. Sicuramente diverso dall’immagine edulcorata che emergeva dai libri di storia della scuola media quando l’artista, pur colpito da avversità di ogni tipo e da disgrazie familiari, riusciva a far rifulgere il suo genio diventando uno dei simboli del Risorgimento.
Ora, quanto al genio (musicale), niente da dire! Nel melodramma ha pochi rivali, per quantità e qualità di produzione. Verdi vivrà nel tempo in cui “la musica italiana, aulica ed aristocratica per tradizione, sta per scoprire il popolo”, e certamente seppe interpretare il cambiamento di gusto musicale, indotto dalla situazione politica e sociale dell’epoca, “dal melodramma amoroso di Bellini e Donizetti al dramma musicale sollecitato da Mazzini”. (le citazioni sono di Massimo Mila, ndr).
Ma dalle lettere, che coprono il periodo dell’intera sua vita, emerge dapprima la figura di un giovane ambizioso (ma di un’ambizione ben supportata da altrettanto talento) che non si rassegna ad una esistenza tranquilla e mediocre in provincia, e in seguito la figura di un imprenditore di sé stesso, che intende vedersi riconoscere, anche economicamente, il valore delle sue opere.
E’ questa la parte più nuova ed interessante della raccolta, e giustamente Rescigno si sofferma, nella presentazione del suo ultimo lavoro, su questi aspetti. Ci presenta un giovane Verdi che, dopo un tirocinio musicale di base con maestri del suo paese, viene a studiare a Milano con una “borsa di studio” del Monte di Pietà e con il sostegno e l’incoraggiamento del direttore della locale società filarmonica, Barezzi. Non viene ammesso al Conservatorio perché verrà considerato insufficiente come pianista anche se promettente come compositore. Rimane comunque a Milano e continua gli studi sotto la guida del maestro Lavigna. E’ un giovane di belle speranza ma squattrinato e alla continua ricerca di una sistemazione stabile e decorosa. Con l’aiuto del suo maestro potrebbe diventare Maestro di cappella del Duomo di Monza (lettera-domanda di assunzione piena di superlativi, come evidentemente si usava) . Impiego che prevede un compenso di circa 2000 lire, stipendio, per l’epoca, di tutto rispetto.
E qui si verifica una vicenda degna della miglior commedia (cinematografica) italiana: alla notizia che Verdi, gloria locale, potrebbe definitivamente trasferirsi “al nord”, gli abitanti di Busseto scendono in piazza, si direbbe oggi, e fanno tanto trambusto da impensierire la Duchessa Maria Luigia.
A seguito di ciò Verdi, amareggiato, rinuncia al probabile incarico monzese e rientra al suo paese rassegnandosi a fare il Maestro di musica del Comune, ruolo modesto con stipendio modesto. Resiste due anni in questa mediocrità ma infine prende la decisione definitiva: si trasferirà senz’altro a Milano e troverà in qualche modo il suo spazio nel mondo musicale. Verifica se il posto nel Duomo di Monza è ancora vacante e, avendo avuto risposta negativa, mette sul mercato una prima opera, Oberto, Conte di S. Bonifacio.
Verdi vende questa sua prima opera per 2000 lire e si rende conto che il suo talento viene sfruttato dagli altri. La cosa non gli sembra giusta (lo scrive in una lettera ad un amico) e si da da fare per cambiare le cose. Dall’alto del suo talento musicale “obbliga” il suo editore musicale, Ricordi, a riconoscergli una percentuale come diritto d’autore, sulla stampa degli spartiti delle sue opere, assicurandosi in questo modo rendite perpetue.
E’ solo il primo passo. La musica di Verdi e il soggetto delle opere sono un grande mix nazional popolare con grande successo di pubblico. Va da sé che le commesse aumentano (verranno in rapida successione Nabucco, I Lombardi, Ernani fino allo Stiiffelio, 13 opere in 8 anni!)e i cachet si aggiornano. Le 2000 lire iniziali salgono fino a 30.000 per toccare le stratosferiche 150.000 de l’Aida e poiché Verdi, oltre che ottimo imprenditore di sé stesso era anche un ottimo amministratore dei suoi soldi, diventerà ben presto un ricco proprietario terriero. Ricco e generoso nei confronti di conoscenti ed artisti in difficoltà (finanzierà tra l’altro la Casa di Riposo per artisti in Milano).
Tra le lettere lette con grande cura da Patrizia Cattaneo molto bella quella scritta ala sorella della seconda moglie pochi giorni prima di morire, dove sono presenti presagi sulla sua fine vicina.
Compaiono anche delle curiosità, come quelle legate alla censura del tempo, per cui nel Rigoletto, il re di Francia diventa duca di Mantova (un re non poteva rivelarsi un essere abbietto!). Non può neanche essere oggetto di un attentato (visti i tempi meglio non mettere strane idee negli spettatori!), così nel Ballo in maschera il re di Svezia diventa il conte Riccardo, improbabile governatore inglese di Boston.
La serata di Novaluna non poteva che concludersi ai tavoli di un ristorante. E qui abbiamo assistito ad un impagabile ed esilarante duetto tra lo stesso Rescigno e un suo accompagnatore, il sig. Monti, appassionato collezionista di incisioni d’epoca, di voci e musiche del melodramma. Abbiamo così potuto ascoltare, alternandoli ai piatti della cena, le voci di Tamagno, Giannini, Caruso, Titta Ruffo (il più grande Jago, secondo Monti) e altri su incisioni risalenti ai primi del ‘900, e della figlia di Giannini, Dusolina, su un disco anni ’30. Dischi 78 giri riprodotti su un grammofono rigorosamente d’epoca!
Degna serata dopo un interessante pomeriggio in libreria.