di giorgio casera
Ci avevo già pensato ai tempi di Primo. A sentirlo parlare di arte, di cinema ( e altro ancora) o leggendo i suoi scritti (nei Bei Momenti, i post dei vari blog, alcuni raccolti da Novaluna nel libro “Novellette degli odori”, e poi, quello che considero un grande racconto. “La grande bua”) riusciva difficile pensare che nella parte più creativa della sua vita avesse fatto il rappresentante commerciale o il marketing manager (peraltro con ottimi risultati) in una grande multinazionale.
Come avrà fatto, pensavo, a discutere con i clienti di computer, di sistemi informativi, di contratti, se dentro gli rodeva un altro fuoco? Poi, però, pensavo che le necessità della vita impongono scelte drastiche, non sempre quelle auspicate. Forse che Fenoglio non commerciava in vini delle Langhe? E Joyce non faceva l’insegnate di inglese quando si trovava a Trieste? e Svevo, e tanti altri ancora? Concludevo: è stato un vero peccato, abbiamo perso uno scrittore di saggi o di romanzi, oppure un critico d’arte, ma non c’erano alternative!
Ma quello di soffocare il proprio talento o di ignorare di possederlo deve essere un fatto più diffuso di quanto si creda. Ma prima o poi viene fuori. Posso citare l’esempio di Claudio (anche lui una vita tra informatica, processi aziendali e così via): in un tempo in cui (opinione personale!) la musica si gusta seduti comodamente nella poltrona di casa o di un teatro, Claudio ha deciso di prendere (seriamente) lezioni di piano.
Non ci resta che assistere ad un suo concerto, quando deciderà di condividere i risultati di questa scelta.
Ma l’esempio più recente di talento ignorato per anni ed infine rivelato è quello di Giuseppe. La sua mostra di quadri visti domenica scorsa alla FAL di Lissone mi ha impressionato per qualità, per varietà di stile, armonia, scelta del colore etc.(non sono un critico d’arte!).
Giuseppe, nella presentazione della mostra, ha confessato di essere arrivato tardi ed in modo casuale a scoprire la sua inclinazione. Ma, visti i risultati, era già una volontà e capacità potenziale, anche se inespressa.
Dicono che un quadro piace quando tra l’immagine rappresentata e chi lo guarda si stabilisce una sintonia, anche irrazionale.
La prima conseguenza di questa sintonia è immaginare come starebbe bene su una parete di casa, in un punto dove ogni giorno, quando lo si guarda, si scoprono particolari e significati nuovi. Beh, domenica ho ripetuto l’esercizio più volte!
P.S. Le foto dei quadri di Peppo sono di Franco Isman.
Questo blog era fermo da qualche anno.
Vorremmo ridargli vita dandogli una funzione
un po' diversa, quella di BACHECA,
dove chiunque tra i nostri soci e amici
possa postare direttamente considerazioni,
pensieri, suggestioni, filmati, propri o altrui.
Qui le istruzioni per l'uso.
Visitate anche la nostra pagina Facebook
giovedì 27 febbraio 2014
giovedì 16 gennaio 2014
ricordi di famiglia: i Foà
di annalisa
Arnoldo e suo fratello Piero erano vecchi amici di Giogio e Piero Colombo, papà e zio di Alberto. Una amicizia allegra che risaliva su per li rami ai loro genitori fino dai tempi in cui erano tutti e quattro, i nonni Foà e i nonni Colombo, giovani sposi a Ferrara.
Dirce e Valentino Foà, Ilda e Alessandro Colombo erano stati vicini di casa e avevano poi mantenuto rapporti per tutta la vita, attraverso trasferimenti e vicissitudini fino a quando i Colombo sono scomparsi tragicamente nella shoah.
 In casa Colombo si seguivano con interesse e gioia ma senza eccessi, le
glorie di Arnoldo in teatro alla tivvù e al cinema, e i due Pieri si
scrivevano e si vedevano appena era possibile. Fra Firenze e Monza la
distanza non era così trascurabile come adesso.
In casa Colombo si seguivano con interesse e gioia ma senza eccessi, le
glorie di Arnoldo in teatro alla tivvù e al cinema, e i due Pieri si
scrivevano e si vedevano appena era possibile. Fra Firenze e Monza la
distanza non era così trascurabile come adesso.
 A Firenze infatti abitava Piero Foà, dove i genitori gestivano un
negozio di ferramenta in una stradina dietro Piazza Santa Maria Novella.
Era uno di quei negozi scuri come antri, pieni di cassettiere di viti e
chiodi e di ogni sorta di materiali, con un odore di ferro gomma e
ruggine. Somigliava un po' al Ferrario ancora in auge, per fortuna, a Monza.
A Firenze infatti abitava Piero Foà, dove i genitori gestivano un
negozio di ferramenta in una stradina dietro Piazza Santa Maria Novella.
Era uno di quei negozi scuri come antri, pieni di cassettiere di viti e
chiodi e di ogni sorta di materiali, con un odore di ferro gomma e
ruggine. Somigliava un po' al Ferrario ancora in auge, per fortuna, a Monza.
Io da ragazzina, ancora lontanissima dal matrimonio e dall'emigrazione al nord, avevo l'incarico insieme ad altri giovani ebrei, di raccogliere le offerte per la comunità ebraica, presso le famiglie e i negozianti di una certa zona. Andavo anche dai Foà. La signora era gentile, vestita di nero, alla cassa, lui burbero e, nel mio ricordo, alto magro e con un camice grigio per non sporcarsi i vestiti, mi faceva un po' paura.
 Piero Foà, a differenza di di Arnoldo che aveva altro da fare, è sempre
stato attivo nella Comunità ebraica fiorentina, era anche amico dei miei
genitori e collaborava con la mia mamma Elena in imprese benefiche e
attività culturali.
Piero Foà, a differenza di di Arnoldo che aveva altro da fare, è sempre
stato attivo nella Comunità ebraica fiorentina, era anche amico dei miei
genitori e collaborava con la mia mamma Elena in imprese benefiche e
attività culturali.
In questi giorni della morte di Arnoldo Foà sono tornati alla mente mia e di Alberto questi ricordi minimi di gente buona e gentile, simile a quella descritta da Primo Levi nel suo racconto Argon del Sistema Periodico.
Le foto le ho prese da Google tranne questa, emersa inopinatamente
rovistando nel fondo del computer:
Arnoldo e suo fratello Piero erano vecchi amici di Giogio e Piero Colombo, papà e zio di Alberto. Una amicizia allegra che risaliva su per li rami ai loro genitori fino dai tempi in cui erano tutti e quattro, i nonni Foà e i nonni Colombo, giovani sposi a Ferrara.
Dirce e Valentino Foà, Ilda e Alessandro Colombo erano stati vicini di casa e avevano poi mantenuto rapporti per tutta la vita, attraverso trasferimenti e vicissitudini fino a quando i Colombo sono scomparsi tragicamente nella shoah.
 In casa Colombo si seguivano con interesse e gioia ma senza eccessi, le
glorie di Arnoldo in teatro alla tivvù e al cinema, e i due Pieri si
scrivevano e si vedevano appena era possibile. Fra Firenze e Monza la
distanza non era così trascurabile come adesso.
In casa Colombo si seguivano con interesse e gioia ma senza eccessi, le
glorie di Arnoldo in teatro alla tivvù e al cinema, e i due Pieri si
scrivevano e si vedevano appena era possibile. Fra Firenze e Monza la
distanza non era così trascurabile come adesso.
 A Firenze infatti abitava Piero Foà, dove i genitori gestivano un
negozio di ferramenta in una stradina dietro Piazza Santa Maria Novella.
Era uno di quei negozi scuri come antri, pieni di cassettiere di viti e
chiodi e di ogni sorta di materiali, con un odore di ferro gomma e
ruggine. Somigliava un po' al Ferrario ancora in auge, per fortuna, a Monza.
A Firenze infatti abitava Piero Foà, dove i genitori gestivano un
negozio di ferramenta in una stradina dietro Piazza Santa Maria Novella.
Era uno di quei negozi scuri come antri, pieni di cassettiere di viti e
chiodi e di ogni sorta di materiali, con un odore di ferro gomma e
ruggine. Somigliava un po' al Ferrario ancora in auge, per fortuna, a Monza.
Io da ragazzina, ancora lontanissima dal matrimonio e dall'emigrazione al nord, avevo l'incarico insieme ad altri giovani ebrei, di raccogliere le offerte per la comunità ebraica, presso le famiglie e i negozianti di una certa zona. Andavo anche dai Foà. La signora era gentile, vestita di nero, alla cassa, lui burbero e, nel mio ricordo, alto magro e con un camice grigio per non sporcarsi i vestiti, mi faceva un po' paura.
 Piero Foà, a differenza di di Arnoldo che aveva altro da fare, è sempre
stato attivo nella Comunità ebraica fiorentina, era anche amico dei miei
genitori e collaborava con la mia mamma Elena in imprese benefiche e
attività culturali.
Piero Foà, a differenza di di Arnoldo che aveva altro da fare, è sempre
stato attivo nella Comunità ebraica fiorentina, era anche amico dei miei
genitori e collaborava con la mia mamma Elena in imprese benefiche e
attività culturali.
In questi giorni della morte di Arnoldo Foà sono tornati alla mente mia e di Alberto questi ricordi minimi di gente buona e gentile, simile a quella descritta da Primo Levi nel suo racconto Argon del Sistema Periodico.
Le foto le ho prese da Google tranne questa, emersa inopinatamente
rovistando nel fondo del computer:
mercoledì 25 dicembre 2013
Lettera a Papa Francesco
di Alberto
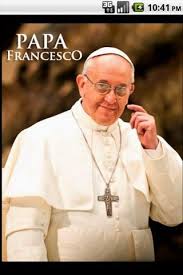
Le
autorità religiose locali, che hanno meritoriamente restaurato e
messo a reddito una serie di vecchie case nelle adiacenze della
cattedrale, si comportano come un'immobiliare, hanno privatizzato di
fatto una strada comunale e il piccolo parco urbano adiacente,
utilizzandoli come pertinenza delle suddette abitazioni. Di fronte
alle contestazioni fanno finta di niente.
Buongiorno,
Santità,
malgrado
io sia decisamente di un'altra parrocchia, ebreo e miscredente, sono
un Suo sincero estimatore.
Apprezzo
molto le Sue aperture e
il fatto che accetti di mettersi in relazione, anche epistolare, con
gli altri. Ho deciso quindi di scriverLe anch'io.
Per
risparmiare il francobollo e per non metterLa in condizione di
pensare, anche per un solo momento di dovermi una risposta, Le scrivo
una lettera aperta:
Lo
faccio perché ritengo di star subendo un torto dalle autorità
ecclesiastiche della mia città e vorrei avere aiuto.
Le
spiego: abito a Monza, in via canonica 18.
Si tratta di una via che
ha origine in piazza del Duomo, rasenta la canonica dalla quale
prende il nome, e con un percorso tortuoso e interessato da alcuni
gradini gira intorno all'abside, passa davanti casa mia, e sfocia in
via Lambro.
E'
a tutti gli effetti una pubblica via, sennonché da qualche anno, in
corrispondenza dei lavori per la sistemazione del magnifico,
importantissimo museo del Duomo, è stato installato un cancello che
taglia in due la strada e impedisce di percorrerla per intero.
Ora,
i lavori sono finiti da un pezzo, ma il brutto cancello non solo è
rimasto, ma viene tenuto sempre chiuso, in spregio alla ragione, al
buon senso e perfino ad una convenzione tra il Comune e la parrocchia
del Duomo che ne prevede l'apertura, almeno nelle ore diurne.
Di tanto in tanto qualche pellegrino rimane imprigionato, effetto zoo..
Le
autorità civili, forse per eccesso di timidezza, non fanno applicare
la convenzione; i cittadini arrivano al cancello e sono costretti a
tornare indietro e a circumnavigare la cattedrale senza rendersi
conto che gli è stata di fatto sequestrata insieme alla via
canonica, una delle più suggestive zone della città. La saluto,
Santità, le faccio i miei migliori auguri, e La prego di far
arrivare fin qui la Sua voce.
Alberto Colombo
le foto, come si vede dalla pessima qualità, sono mie; quella di Papa Francesco di play.google.com o ABMdesign
mercoledì 13 novembre 2013
Bastian contrario
di Gauss
Da sinistra, Gherardo Colombo, la presidente di Novaluna
Annalisa Bemporad e Gustavo Zagrebelski
Anni fa, da
un viaggio di lavoro (credo in India, allora ero sempre in giro) ho portato in
regalo a mia moglie un bel braccialetto d’argento tempestato di pietre scure. E’
un cerchietto a forma di serpente con la testa che tenta di morsicare l’estremità
della sua stessa coda. Non sapevo che si chiamasse uroboro (parola di radice
greca, letteralmente “che morde la coda”) né che fosse una antichissima figura
mirante a significare il mito dell’eterno ritorno, l’unione della fine con l’inizio.
L’ho saputo solo venerdì scorso da Gustavo Zagrebelski durante l’interessante e
affollata serata di Novaluna che l’ha invitato, insieme a Gherardo Colombo, a
dibattere il tema “Quale democrazia per l’Italia?”
L'uroboro indiano
Zagrebelski
ricorre all’immagine dell’uroboro per dare un’idea plastica della
“finanziarizzazione” dell’economia e della politica in cui vede una delle più
pericolose minacce alla democrazia. Il denaro – dice Zagrebeslki – non è più
destinato come in passato a procurare altre cose, costruire chiese e palazzi,
nutrire popolazioni, armare eserciti e fare guerre, cose utili o dannose, ma
comunque cose diverse dal denaro. Oggi il denaro serve a fare denaro. Lungi
dall’essere uno strumento al servizio del sovrano (il fallimento degli Stati è una
novità del nostro tempo) si è messo al servizio di se stesso e con ciò si è seduto sul trono al posto
del popolo sovrano (“pecunia regina mundi”). Un detto tramandato dalla saggezza
popolare ammonisce che i soldi sono lo sterco del demonio. Nell’uroboro il serpente, personificazione edenica del demonio, avvicina la
bocca alla coda per nutrirsi dei suoi propri escrementi, con ciò producendone
di nuovi in un processo senza inizio e senza fine. E proprio come l’uroboro, anche la
finanza è un mostro che divora denaro per produrre denaro. L’avessi saputo
prima di quel viaggio, l’uroboro di mia moglie sarebbe rimasto al suo posto nella
gioielleria indiana, mica è roba da farne dono alle signore.
Michelangelo, Peccato originale e cacciata dal Paradiso terrestre, Roma (Cappella Sistina)
Salto di
palo in frasca – un esercizio in cui per la verità si sono cimentati con
successo anche i nostri oratori – per
commentare da bastian contrario un paio di altri passaggi della
memorabile conferenza di Novaluna.
Sia
Zagrebelski che Colombo segnalano con forza che la democrazia non è il
“bengodi”, è un sistema complicato che chiede attenzione e coinvolgimento perché
nel concetto di “res publica” è contenuto sì il senso della comproprietà, della
condivisione dei pubblici beni, ma insieme anche quello della ripartizione del peso
del potere su tante spalle: «Governare – dice Zagrebelski – non è una festa».
Tiziano, Sisifo, Madrid (Museo del Prado)
Colombo si
spinge a sostenere che la libertà è perfino dannosa, se non è assistita
dall’impegno che occorre per gestirla, tanto varrebbe tornare alla società
gerarchica e piramidale dei tempi andati, che si reggeva sull’obbedienza,
mentre la democrazia necessita di molto di più. Perché funzioni ognuno deve
dare il suo contributo di conoscenza e responsabilità, deve battersi di persona
per ciò che gli preme, non fidarsi di altri né affidarsi ad altri. Il pubblico
in sala, me compreso, ascolta in silenzio, come avvinto in un esame di
coscienza collettivo («E io, lo faccio il mio democratico dovere? »). Arriva però a scuotermi un'affermazione: “la democrazia è incompatibile con la delega”. Questo
no, proprio non ci sto. Sarà incompatibile con la democrazia diretta, quella
che piace ai grillini che straparlano di mandato imperativo, che si illudono di
controllare tutto col web, sarà forse incompatibile con la democrazia referendaria
di Pannella, che chiamerebbe il popolo a consulto anche per il prezzo del
biglietto del tram, non certo con la “vecchia” democrazia
parlamentare e rappresentativa che piace a me (piaceva anche ai padri costituenti), quella fondata sulla delega di
rappresentanza che da elettore affido al mio rappresentante eletto senza
pretendere di pilotarlo a distanza (lo so che il porcellum l’ha stravolta, ma non è certo colpa della delega).
La prima seduta dell'Assemblea costituente
Arriva il
momento di raccogliere domande dal pubblico e un malcapitato spettatore, in una
sincera e, col senno di poi, improvvida manifestazione di stima e di fiducia,
chiede sia a Colombo che a Zagrebelski: «Perché non trasformate Libertà e
Giustizia, il vostro “pensatoio” politico, in un partito politico? Avremmo
finalmente persone degne e capaci da eleggere». La risposta di Zagrebelski è garbatamente ironica: «Lei è già iscritto a
Libertà e Giustizia? No? Si iscriva, così potrà contribuire direttamente a quel
miglioramento della politica italiana che si aspetta da noi». A rincarare la
dose provvede Colombo. Non si può sempre assistere, bisogna entrare in campo, schierarsi
e partecipare. Riaffiorano le esperienze del magistrato che ha portato alla
luce i più gravi misfatti dell’Italia repubblicana, Sindona e l’assassinio di
Ambrosoli, la P2, Tangentopoli. Ne parla con amarezza, perché tutto è scivolato
via, nessuno ne parla più, come se non fosse successo nulla. Una nebbia
omertosa, un’ignoranza colpevole. Colpa di chi? Di tutti, la chiamata in
correità non risparmia nessuno. Rivela quella che considera la ragione vera dell’esaurimento
dell’inchiesta Mani pulite e dello scioglimento del pool di magistrati che l'aveva condotta: «Finché mettevamo dentro i politici importanti, le alte sfere
dell’Amministrazione e i grandi industriali la gente si indignava e ci
osannava. Poi abbiamo dovuto occuparci del piccolo cabotaggio, ci sono finiti
fra le mani il macellaio che con un quarto di bue eludeva i controlli della
vigilanza, il finanziere che prendeva la mazzetta, il medico compiacente che
esentava dal servizio militare il rampollo di una famiglia facoltosa, ecc. La
gente ha capito che, uno dopo l’altro, sarebbe arrivato il turno di tutti. E il
favore popolare si è rivoltato in avversione». Una spiegazione plausibile, confermata
anche dal perdurante successo elettorale del partito del lassismo fiscale e penale.
E tuttavia si affaccia una domanda, che rimane senza risposta: «Ma il
magistrato, il pubblico ministero in particolare, non è “soggetto alla legge e
solo alla legge”? O dobbiamo pensare che è “soggetto solo alla legge che non urta il
favore popolare, che oltretutto mica è facile da trovare”?»
Gauss
Gauss
sabato 26 ottobre 2013
Verbania dalla storia alla natura
di giorgio casera
L’autunno può svelare brutte sorprese in una gita al lago. Basta una giornata coperta o addirittura con pioggia per nascondere la vera bellezza della stagione, i colori delle foglie sugli alberi nei parchi e nei boschi. Il verde di mille gradazioni si trasforma in giallo e in rosso nelle latifoglie come l’acero o il faggio, mentre l’abete conserva il suo colore verde scuro, Si parte dunque con qualche patema, sabato 19 ottobre, osservando il cielo coperto e, lungo il percorso in autostrada per Verbania, una diffusa foschia in lontananza. Ma non andiamo a Verbania solo con obiettivi naturalistici: la prima meta, che impegnerà l’intera mattinata, è Fondotoce, frazione di Verbania, dove visiteremo la Casa della Resistenza e il Parco annesso. La Casa è stata costruita a ridosso del luogo dove nel giugno 1944 furono fucilati 43 partigiani (uno dei quali si salvò rocambolescamente), partigiani rastrellati nelle valli a NO del lago Maggiore, la Valdossola e la Valgrande, dove dopo l’8 settembre 1943 si era concentrata una forte attività partigiana (che darà luogo alla costituzione della Repubblica dell’Ossola, primo territorio libero nel Nord Italia ancora occupato dai nazifascisti). Arriviamo alla Casa alle 10, puntuali, e ci accoglie Giorgio Danini, insieme ad alcuni volontari, che aiutano nella gestione della casa. Danini è un appassionato studioso di storia della Resistenza della regione Verbano/Cusio/Ossola; è nato a Fondotoce subito dopo la guerra ed è cresciuto in un ambiente familiare schierato dalla parte “giusta”, con congiunti impegnati nella lotta armata. Ci fa accomodare in una grande sala per conferenze e ci fornisce il quadro della situazione esistente nel 1944, con le formazioni partigiane (di ogni colore, ci tiene a precisare), ciascuna con la sua dislocazione nelle valli, a contrastare i presidi dei tedeschi e dei fascisti, situati lungo le rive del lago Maggiore. Il movimento partigiano è forte e organizzato e darà filo da torcere al nemico occupante. Componenti delle formazioni sono abitanti della zona, ma anche oppositori al regime provenienti dal Piemonte a dalla Lombardia (Gianni Citterio è caduto in queste valli in combattimento), militari che dopo l’8 settembre scelgono la lotta armata contro tedeschi e fascisti e giovani renitente alla leva nell’esercito di Graziani. L’importanza che assume la lotta armata in queste valli, la vicinanza con la Svizzera, preziosa per il contatto con gli Alleati, fa si che il CLN di Milano nomini un ufficiale di collegamento, nella persona di Giambattista Stucchi (che qui, a dimostrazione delle regole della clandestinità, conoscevano anche recentemente con il solo nome di battaglia, Federici). Vengono così alla luce i significativi legami tra Fondotoce e Monza, che Danini sottolinea. Terminata questa premessa, Danini ci guida nel Parco esterno alla Casa. Vedremo così che l’episodio della fucilazione dei partigiani è stato solo uno spunto per costruire un luogo della memoria e della storia sui più ampi avvenimenti della 2.a guerra mondiale e della resistenza al nazifascismo. Il Parco cioè ricorda con distinti monumenti l’eccidio degli ebrei in varie località del lago Maggiore, il ruolo della donna nella Resistenza, il contributo dei giorgiani, disertori dell’esercito tedesco, alla lotta partigiana, i deportati nei campi di concentramento e infine, con un lungo muro ove sono riportati tutti i nomi, i numerosi caduti della guerra di liberazione della provincia di Novara (che fino a qualche anno fa comprendeva il Verbano/Cusio/Ossola). Percorriamo il Parco in silenzio, solo Danini parla, fino al luogo della fucilazione. I dettagli che ci racconta, le fucilazioni a tre per volta, gli abbracci tra i condannati, i corpi che cadono uno sopra l’altro, ci fanno rivivere la scena. Rientriamo nella Casa e visitiamo le varie sale: c’è quella dei video sugli orrori della guerra, quella delle mostre estemporanee (è in corso quella sulle 4 giornate di Napoli), quella sulla fucilazione del giugno 1944 (con i documenti d’identità dei fucilati appesi alla parete, riprodotti e ingranditi), la biblioteca, che comprende l’archivio di Aldo Aniasi, ex sindaco di Milano, che è stato partigiano qui, tutte sale che ruotano intorno alla sala conferenze, costituendo un variegato percorso didattico. Perché, dice Danini, la Casa è visitata da gruppi, associazioni ma soprattutto da scuole, per una lezione di storia “dal vivo”. La Casa, peraltro, non è un museo, sottolinea ancora, ma un centro culturale vivo, che ospita incontri e manifestazioni culturali in senso lato.
Arriviamo così alle 12.30 e ci spostiamo a piedi per il pranzo in una vicina trattoria, “La gallina che fuma”. Anche qui un altro aneddoto storico: la trattoria ha sede nella costruzione dove nel 1944 era insediato un posto di blocco fascista, i cui componenti, una quarantina, furono tutti catturati durante un’azione partigiana (e successivamente liberati, non esistendo strutture per custodire prigionieri). La scelta del luogo per la fucilazione volle essere una risposta a quello smacco. Dopo aver pranzato, bene, siamo pronti per il secondo obiettivo della gita, i giardini della Villa Taranto di Pallanza, altra frazione di Verbania. Un sole sempre più rinfrancato continua ad accompagnarci ed in pochi minuti giungiamo all’ingresso della Villa. Se c’era qualche riserva sulla data scelta per la visita (fine ottobre, e i giardini chiudono ai primi di novembre), questa svanisce alla vista delle dalie (nel cosiddetto Labirinto delle dahlie) , un’esplosione di colori originato da trecento varietà. Ma prima e dopo le dalie, il percorso guidato ci permette di apprezzare quanto di meglio possa offrire un giardino: specie arboree di ogni tipo (che forniscono scorci che solo l’autunno, con i suoi colori, rende così suggestivi), fontane e sculture, serre, laghetti e vasche per la stupenda flora acquatica. Il tutto distribuito armonicamente su colline a vallette prospicienti il lago, e ancora, all’interno del giardino, la Villa e il mausoleo del fondatore di Villa Taranto, il capitano Neil Mc Eacharn. Ma non mi dilungo nella descrizione, preferendo invitare il lettore ad osservare le splendide foto di Massimo Vanzi, che precedono e seguono, perché, come avrebbe detto il capitano, parafrasando un noto proverbio inglese, le immagini “speak louder than words”.
L’autunno può svelare brutte sorprese in una gita al lago. Basta una giornata coperta o addirittura con pioggia per nascondere la vera bellezza della stagione, i colori delle foglie sugli alberi nei parchi e nei boschi. Il verde di mille gradazioni si trasforma in giallo e in rosso nelle latifoglie come l’acero o il faggio, mentre l’abete conserva il suo colore verde scuro, Si parte dunque con qualche patema, sabato 19 ottobre, osservando il cielo coperto e, lungo il percorso in autostrada per Verbania, una diffusa foschia in lontananza. Ma non andiamo a Verbania solo con obiettivi naturalistici: la prima meta, che impegnerà l’intera mattinata, è Fondotoce, frazione di Verbania, dove visiteremo la Casa della Resistenza e il Parco annesso. La Casa è stata costruita a ridosso del luogo dove nel giugno 1944 furono fucilati 43 partigiani (uno dei quali si salvò rocambolescamente), partigiani rastrellati nelle valli a NO del lago Maggiore, la Valdossola e la Valgrande, dove dopo l’8 settembre 1943 si era concentrata una forte attività partigiana (che darà luogo alla costituzione della Repubblica dell’Ossola, primo territorio libero nel Nord Italia ancora occupato dai nazifascisti). Arriviamo alla Casa alle 10, puntuali, e ci accoglie Giorgio Danini, insieme ad alcuni volontari, che aiutano nella gestione della casa. Danini è un appassionato studioso di storia della Resistenza della regione Verbano/Cusio/Ossola; è nato a Fondotoce subito dopo la guerra ed è cresciuto in un ambiente familiare schierato dalla parte “giusta”, con congiunti impegnati nella lotta armata. Ci fa accomodare in una grande sala per conferenze e ci fornisce il quadro della situazione esistente nel 1944, con le formazioni partigiane (di ogni colore, ci tiene a precisare), ciascuna con la sua dislocazione nelle valli, a contrastare i presidi dei tedeschi e dei fascisti, situati lungo le rive del lago Maggiore. Il movimento partigiano è forte e organizzato e darà filo da torcere al nemico occupante. Componenti delle formazioni sono abitanti della zona, ma anche oppositori al regime provenienti dal Piemonte a dalla Lombardia (Gianni Citterio è caduto in queste valli in combattimento), militari che dopo l’8 settembre scelgono la lotta armata contro tedeschi e fascisti e giovani renitente alla leva nell’esercito di Graziani. L’importanza che assume la lotta armata in queste valli, la vicinanza con la Svizzera, preziosa per il contatto con gli Alleati, fa si che il CLN di Milano nomini un ufficiale di collegamento, nella persona di Giambattista Stucchi (che qui, a dimostrazione delle regole della clandestinità, conoscevano anche recentemente con il solo nome di battaglia, Federici). Vengono così alla luce i significativi legami tra Fondotoce e Monza, che Danini sottolinea. Terminata questa premessa, Danini ci guida nel Parco esterno alla Casa. Vedremo così che l’episodio della fucilazione dei partigiani è stato solo uno spunto per costruire un luogo della memoria e della storia sui più ampi avvenimenti della 2.a guerra mondiale e della resistenza al nazifascismo. Il Parco cioè ricorda con distinti monumenti l’eccidio degli ebrei in varie località del lago Maggiore, il ruolo della donna nella Resistenza, il contributo dei giorgiani, disertori dell’esercito tedesco, alla lotta partigiana, i deportati nei campi di concentramento e infine, con un lungo muro ove sono riportati tutti i nomi, i numerosi caduti della guerra di liberazione della provincia di Novara (che fino a qualche anno fa comprendeva il Verbano/Cusio/Ossola). Percorriamo il Parco in silenzio, solo Danini parla, fino al luogo della fucilazione. I dettagli che ci racconta, le fucilazioni a tre per volta, gli abbracci tra i condannati, i corpi che cadono uno sopra l’altro, ci fanno rivivere la scena. Rientriamo nella Casa e visitiamo le varie sale: c’è quella dei video sugli orrori della guerra, quella delle mostre estemporanee (è in corso quella sulle 4 giornate di Napoli), quella sulla fucilazione del giugno 1944 (con i documenti d’identità dei fucilati appesi alla parete, riprodotti e ingranditi), la biblioteca, che comprende l’archivio di Aldo Aniasi, ex sindaco di Milano, che è stato partigiano qui, tutte sale che ruotano intorno alla sala conferenze, costituendo un variegato percorso didattico. Perché, dice Danini, la Casa è visitata da gruppi, associazioni ma soprattutto da scuole, per una lezione di storia “dal vivo”. La Casa, peraltro, non è un museo, sottolinea ancora, ma un centro culturale vivo, che ospita incontri e manifestazioni culturali in senso lato.
Arriviamo così alle 12.30 e ci spostiamo a piedi per il pranzo in una vicina trattoria, “La gallina che fuma”. Anche qui un altro aneddoto storico: la trattoria ha sede nella costruzione dove nel 1944 era insediato un posto di blocco fascista, i cui componenti, una quarantina, furono tutti catturati durante un’azione partigiana (e successivamente liberati, non esistendo strutture per custodire prigionieri). La scelta del luogo per la fucilazione volle essere una risposta a quello smacco. Dopo aver pranzato, bene, siamo pronti per il secondo obiettivo della gita, i giardini della Villa Taranto di Pallanza, altra frazione di Verbania. Un sole sempre più rinfrancato continua ad accompagnarci ed in pochi minuti giungiamo all’ingresso della Villa. Se c’era qualche riserva sulla data scelta per la visita (fine ottobre, e i giardini chiudono ai primi di novembre), questa svanisce alla vista delle dalie (nel cosiddetto Labirinto delle dahlie) , un’esplosione di colori originato da trecento varietà. Ma prima e dopo le dalie, il percorso guidato ci permette di apprezzare quanto di meglio possa offrire un giardino: specie arboree di ogni tipo (che forniscono scorci che solo l’autunno, con i suoi colori, rende così suggestivi), fontane e sculture, serre, laghetti e vasche per la stupenda flora acquatica. Il tutto distribuito armonicamente su colline a vallette prospicienti il lago, e ancora, all’interno del giardino, la Villa e il mausoleo del fondatore di Villa Taranto, il capitano Neil Mc Eacharn. Ma non mi dilungo nella descrizione, preferendo invitare il lettore ad osservare le splendide foto di Massimo Vanzi, che precedono e seguono, perché, come avrebbe detto il capitano, parafrasando un noto proverbio inglese, le immagini “speak louder than words”.
Etichette:
fondotoce,
resistenza,
verbania,
villa taranto
lunedì 1 luglio 2013
Verdi attraverso le lettere
di giorgio casera
E’ un Verdi inedito quello che compare attraverso le lettere amorevolmente raccolte da Eduardo Rescigno e stampate da Einaudi in un bel volumone. Sicuramente diverso dall’immagine edulcorata che emergeva dai libri di storia della scuola media quando l’artista, pur colpito da avversità di ogni tipo e da disgrazie familiari, riusciva a far rifulgere il suo genio diventando uno dei simboli del Risorgimento.
Ora, quanto al genio (musicale), niente da dire! Nel melodramma ha pochi rivali, per quantità e qualità di produzione. Verdi vivrà nel tempo in cui “la musica italiana, aulica ed aristocratica per tradizione, sta per scoprire il popolo”, e certamente seppe interpretare il cambiamento di gusto musicale, indotto dalla situazione politica e sociale dell’epoca, “dal melodramma amoroso di Bellini e Donizetti al dramma musicale sollecitato da Mazzini”. (le citazioni sono di Massimo Mila, ndr).
Ma dalle lettere, che coprono il periodo dell’intera sua vita, emerge dapprima la figura di un giovane ambizioso (ma di un’ambizione ben supportata da altrettanto talento) che non si rassegna ad una esistenza tranquilla e mediocre in provincia, e in seguito la figura di un imprenditore di sé stesso, che intende vedersi riconoscere, anche economicamente, il valore delle sue opere.
E’ questa la parte più nuova ed interessante della raccolta, e giustamente Rescigno si sofferma, nella presentazione del suo ultimo lavoro, su questi aspetti. Ci presenta un giovane Verdi che, dopo un tirocinio musicale di base con maestri del suo paese, viene a studiare a Milano con una “borsa di studio” del Monte di Pietà e con il sostegno e l’incoraggiamento del direttore della locale società filarmonica, Barezzi. Non viene ammesso al Conservatorio perché verrà considerato insufficiente come pianista anche se promettente come compositore. Rimane comunque a Milano e continua gli studi sotto la guida del maestro Lavigna. E’ un giovane di belle speranza ma squattrinato e alla continua ricerca di una sistemazione stabile e decorosa. Con l’aiuto del suo maestro potrebbe diventare Maestro di cappella del Duomo di Monza (lettera-domanda di assunzione piena di superlativi, come evidentemente si usava) . Impiego che prevede un compenso di circa 2000 lire, stipendio, per l’epoca, di tutto rispetto.
E qui si verifica una vicenda degna della miglior commedia (cinematografica) italiana: alla notizia che Verdi, gloria locale, potrebbe definitivamente trasferirsi “al nord”, gli abitanti di Busseto scendono in piazza, si direbbe oggi, e fanno tanto trambusto da impensierire la Duchessa Maria Luigia.
A seguito di ciò Verdi, amareggiato, rinuncia al probabile incarico monzese e rientra al suo paese rassegnandosi a fare il Maestro di musica del Comune, ruolo modesto con stipendio modesto. Resiste due anni in questa mediocrità ma infine prende la decisione definitiva: si trasferirà senz’altro a Milano e troverà in qualche modo il suo spazio nel mondo musicale. Verifica se il posto nel Duomo di Monza è ancora vacante e, avendo avuto risposta negativa, mette sul mercato una prima opera, Oberto, Conte di S. Bonifacio.Giuseppe Verdi
L’opera ha un discreto successo, 14 rappresentazioni alla Scala e allora arrivano le commesse. In quei tempi erano i vari impresari a commettere un’opera al compositore. Quest’ultimo riceveva il compenso pattuito a lavoro concluso e da quel momento l’opera diventava di proprietà del committente, per qualunque successivo sfruttamento commerciale.
Verdi vende questa sua prima opera per 2000 lire e si rende conto che il suo talento viene sfruttato dagli altri. La cosa non gli sembra giusta (lo scrive in una lettera ad un amico) e si da da fare per cambiare le cose. Dall’alto del suo talento musicale “obbliga” il suo editore musicale, Ricordi, a riconoscergli una percentuale come diritto d’autore, sulla stampa degli spartiti delle sue opere, assicurandosi in questo modo rendite perpetue.
E’ solo il primo passo. La musica di Verdi e il soggetto delle opere sono un grande mix nazional popolare con grande successo di pubblico. Va da sé che le commesse aumentano (verranno in rapida successione Nabucco, I Lombardi, Ernani fino allo Stiiffelio, 13 opere in 8 anni!)e i cachet si aggiornano. Le 2000 lire iniziali salgono fino a 30.000 per toccare le stratosferiche 150.000 de l’Aida e poiché Verdi, oltre che ottimo imprenditore di sé stesso era anche un ottimo amministratore dei suoi soldi, diventerà ben presto un ricco proprietario terriero. Ricco e generoso nei confronti di conoscenti ed artisti in difficoltà (finanzierà tra l’altro la Casa di Riposo per artisti in Milano).
Lettera a Boito
Tra le lettere lette con grande cura da Patrizia Cattaneo molto bella quella scritta ala sorella della seconda moglie pochi giorni prima di morire, dove sono presenti presagi sulla sua fine vicina.
Compaiono anche delle curiosità, come quelle legate alla censura del tempo, per cui nel Rigoletto, il re di Francia diventa duca di Mantova (un re non poteva rivelarsi un essere abbietto!). Non può neanche essere oggetto di un attentato (visti i tempi meglio non mettere strane idee negli spettatori!), così nel Ballo in maschera il re di Svezia diventa il conte Riccardo, improbabile governatore inglese di Boston.
La serata di Novaluna non poteva che concludersi ai tavoli di un ristorante. E qui abbiamo assistito ad un impagabile ed esilarante duetto tra lo stesso Rescigno e un suo accompagnatore, il sig. Monti, appassionato collezionista di incisioni d’epoca, di voci e musiche del melodramma. Abbiamo così potuto ascoltare, alternandoli ai piatti della cena, le voci di Tamagno, Giannini, Caruso, Titta Ruffo (il più grande Jago, secondo Monti) e altri su incisioni risalenti ai primi del ‘900, e della figlia di Giannini, Dusolina, su un disco anni ’30. Dischi 78 giri riprodotti su un grammofono rigorosamente d’epoca!
Degna serata dopo un interessante pomeriggio in libreria.
E’ un Verdi inedito quello che compare attraverso le lettere amorevolmente raccolte da Eduardo Rescigno e stampate da Einaudi in un bel volumone. Sicuramente diverso dall’immagine edulcorata che emergeva dai libri di storia della scuola media quando l’artista, pur colpito da avversità di ogni tipo e da disgrazie familiari, riusciva a far rifulgere il suo genio diventando uno dei simboli del Risorgimento.
Ora, quanto al genio (musicale), niente da dire! Nel melodramma ha pochi rivali, per quantità e qualità di produzione. Verdi vivrà nel tempo in cui “la musica italiana, aulica ed aristocratica per tradizione, sta per scoprire il popolo”, e certamente seppe interpretare il cambiamento di gusto musicale, indotto dalla situazione politica e sociale dell’epoca, “dal melodramma amoroso di Bellini e Donizetti al dramma musicale sollecitato da Mazzini”. (le citazioni sono di Massimo Mila, ndr).
Ma dalle lettere, che coprono il periodo dell’intera sua vita, emerge dapprima la figura di un giovane ambizioso (ma di un’ambizione ben supportata da altrettanto talento) che non si rassegna ad una esistenza tranquilla e mediocre in provincia, e in seguito la figura di un imprenditore di sé stesso, che intende vedersi riconoscere, anche economicamente, il valore delle sue opere.
E’ questa la parte più nuova ed interessante della raccolta, e giustamente Rescigno si sofferma, nella presentazione del suo ultimo lavoro, su questi aspetti. Ci presenta un giovane Verdi che, dopo un tirocinio musicale di base con maestri del suo paese, viene a studiare a Milano con una “borsa di studio” del Monte di Pietà e con il sostegno e l’incoraggiamento del direttore della locale società filarmonica, Barezzi. Non viene ammesso al Conservatorio perché verrà considerato insufficiente come pianista anche se promettente come compositore. Rimane comunque a Milano e continua gli studi sotto la guida del maestro Lavigna. E’ un giovane di belle speranza ma squattrinato e alla continua ricerca di una sistemazione stabile e decorosa. Con l’aiuto del suo maestro potrebbe diventare Maestro di cappella del Duomo di Monza (lettera-domanda di assunzione piena di superlativi, come evidentemente si usava) . Impiego che prevede un compenso di circa 2000 lire, stipendio, per l’epoca, di tutto rispetto.
E qui si verifica una vicenda degna della miglior commedia (cinematografica) italiana: alla notizia che Verdi, gloria locale, potrebbe definitivamente trasferirsi “al nord”, gli abitanti di Busseto scendono in piazza, si direbbe oggi, e fanno tanto trambusto da impensierire la Duchessa Maria Luigia.
A seguito di ciò Verdi, amareggiato, rinuncia al probabile incarico monzese e rientra al suo paese rassegnandosi a fare il Maestro di musica del Comune, ruolo modesto con stipendio modesto. Resiste due anni in questa mediocrità ma infine prende la decisione definitiva: si trasferirà senz’altro a Milano e troverà in qualche modo il suo spazio nel mondo musicale. Verifica se il posto nel Duomo di Monza è ancora vacante e, avendo avuto risposta negativa, mette sul mercato una prima opera, Oberto, Conte di S. Bonifacio.
Verdi vende questa sua prima opera per 2000 lire e si rende conto che il suo talento viene sfruttato dagli altri. La cosa non gli sembra giusta (lo scrive in una lettera ad un amico) e si da da fare per cambiare le cose. Dall’alto del suo talento musicale “obbliga” il suo editore musicale, Ricordi, a riconoscergli una percentuale come diritto d’autore, sulla stampa degli spartiti delle sue opere, assicurandosi in questo modo rendite perpetue.
E’ solo il primo passo. La musica di Verdi e il soggetto delle opere sono un grande mix nazional popolare con grande successo di pubblico. Va da sé che le commesse aumentano (verranno in rapida successione Nabucco, I Lombardi, Ernani fino allo Stiiffelio, 13 opere in 8 anni!)e i cachet si aggiornano. Le 2000 lire iniziali salgono fino a 30.000 per toccare le stratosferiche 150.000 de l’Aida e poiché Verdi, oltre che ottimo imprenditore di sé stesso era anche un ottimo amministratore dei suoi soldi, diventerà ben presto un ricco proprietario terriero. Ricco e generoso nei confronti di conoscenti ed artisti in difficoltà (finanzierà tra l’altro la Casa di Riposo per artisti in Milano).
Tra le lettere lette con grande cura da Patrizia Cattaneo molto bella quella scritta ala sorella della seconda moglie pochi giorni prima di morire, dove sono presenti presagi sulla sua fine vicina.
Compaiono anche delle curiosità, come quelle legate alla censura del tempo, per cui nel Rigoletto, il re di Francia diventa duca di Mantova (un re non poteva rivelarsi un essere abbietto!). Non può neanche essere oggetto di un attentato (visti i tempi meglio non mettere strane idee negli spettatori!), così nel Ballo in maschera il re di Svezia diventa il conte Riccardo, improbabile governatore inglese di Boston.
La serata di Novaluna non poteva che concludersi ai tavoli di un ristorante. E qui abbiamo assistito ad un impagabile ed esilarante duetto tra lo stesso Rescigno e un suo accompagnatore, il sig. Monti, appassionato collezionista di incisioni d’epoca, di voci e musiche del melodramma. Abbiamo così potuto ascoltare, alternandoli ai piatti della cena, le voci di Tamagno, Giannini, Caruso, Titta Ruffo (il più grande Jago, secondo Monti) e altri su incisioni risalenti ai primi del ‘900, e della figlia di Giannini, Dusolina, su un disco anni ’30. Dischi 78 giri riprodotti su un grammofono rigorosamente d’epoca!
Degna serata dopo un interessante pomeriggio in libreria.
venerdì 22 febbraio 2013
Garibaldi si riprende la sua piazza
di Alfredo Viganò
Primi ‘900 in
Piazza
Finalmente dopo 66 anni, l’undici di marzo la Statua in
Marmo di Garibaldi, restaurata, verrà traslata in Piazza Garibaldi e il 17 vi
sarà l’inaugurazione. Gianna Parri per l’Associazione mazziniana ed
io per Novaluna, che abbiamo raccolto i fondi necessari ne siamo
particolarmente lieti avendo vinto la nostra battaglia pluriennale contro i
detrattori dell’Unità d’Italia.
Alfredo Viganò
Il nuovo posizionamento
in Piazza ( fonte Comune)
A mio parere sarà un poco più grande di quanto appare qui
A mio parere sarà un poco più grande di quanto appare qui
Da qualche anno alcuni di noi ( in particolare Gianna Parri per
l’Associazione mazziniana e io per Nova Luna, ci stiamo interessando per
il recupero della statua originale in marmo di Garibaldi e il suo ritorno nella
omonima piazza a Monza.
La statua è di uno scultore egregio Ernesto Bazzaro ( 1859-1937). La
scultura mi risulta la prima dedicata a Garibaldi: già nel 1882 il
Consiglio di Monza decise per il Monumento all’Eroe dei due mondi e dopo
sottoscrizione e concorso fu realizzato affidandolo allo scultore Bazzaro.
Purtroppo poi, ritenendola impropriamente in degrado (1912), fu sostituita con
una copia in bronzo nel 1915, e il Monumento originario finì buttato a
terra nel terreno della scuola. Quella in bronzo, poi emarginata ai
Boschetti in posizione laterale allora (1937) ritenuta migliore, è oggi
visibile tra il fitto delle piante lungo via Margherita di Sa voia. Ci fu nel ’46 anche chi voleva che
Garibaldi fosse posto in Piazza Citterio spostando Vittorio Emanuele nei Giardini di
Villa reale.
Devo dire che tanti anni fa ero nel cortile dell’Istituto Olivetti
per un incontro, passeggiando, forse ero con Crippa, già assessore e oggi
Presidente di Novaluna, avevo notato con sorpresa, che contro la muratura
verso via De Leyva e sotto tubi di cemento e cartelli stradali giaceva a terra
la Statua che è opera monumentale e storicamente rilevante. Monza non è aliena da
simili comportamenti, purtroppo, vista la demolizione di opere rilevanti e
monumentali. L’allora assessore era l’indimenticabile amica Giovanna Mussi che
fece provvedere a spostare e alzare la statua contro l’altro alto muro di
confine opposto.
Mi interessai poi della cosa quando ero assessore e preparammo un progetto
per il restauro e chiedemmo parere alla Soprintendenza. Sono passati anni e
anche per interpellanza in Consiglio come consigliere e le richieste di Gianna, per la attenzione dell’assessore Mangone , si è ripresa la questione in
occasione del centenario dell’Unità d’Italia.
Il progetto anni 2004
Qualche bega con il Sindaco di allora e la Lega, contro
Garibaldi, hanno ritardato di molto il restauro. Soldi raccolti da privati non
si erano neppure potuti spendere per irragionevoli motivi. Tuttavia
l’assessore riuscì con buona volontà a far partire il restauro della Statua
e ora mancavano soldi per completar il tutto col trasferimento e la scelta
della posizione nella Piazza..
Manca purtroppo la targa in bassorilievo dove Garibaldi era ritratto
seduto che guardava il mare dall’isola di Caprera e probabilmente finita
fusa per la scellerata guerra. La puntigliosa ricerca dell’amica Gianna è
rimasta infruttuosa La statua è mutilata della mano sinistra e resterà
così.
Il Monumento ora
all’Olivetti
Ci siamo rimessi all’opera completando con successo la raccolta
di fondi e ora, dopo l’approvazione della Soprintendenza e il
coordinamento del Comune (arch. Fulvia Bonfanti ), siamo a termine. Tra
pochi giorni
(11 di marzo) la Statua verrà imbracata con una apposita gabbia di ferro e traslata in Piazza Garibaldi dove si è provveduto in queste settimane a sistemare il basamento. Basamento modificato in altezza ,ma simile a quello
originario. La posizione è quella nello slargo a lato destro della facciata de
Tribunale, come era previsto nella prima proposta all'epoca della
Amministrazione Faglia.. Il 17 vi sarà l’inaugurazione a cui saremo
presenti spero in molti.
(11 di marzo) la Statua verrà imbracata con una apposita gabbia di ferro e traslata in Piazza Garibaldi dove si è provveduto in queste settimane a sistemare il basamento. Basamento modificato in altezza ,
Un grazie a tutti anche per le donazioni liberali che hanno consentito
l’attuazione di questo desiderio da anni coltivato e pensiamo proprio che
la Città ne guadagni. Tutti finalmente potranno ammirare l’opera e
ricordare un grande Personaggio italiano, di statura europea e mondiale.
lunedì 18 febbraio 2013
Piccolo particolare
di Alberto
Si sussurra che sia stato l'autore della famigerata domanda sul controfagotto a lascia o raddoppia, che fece versare inchiostro a fiumi sui giornali dell'epoca, e che si difendesse dalle accuse di eccessiva difficoltà sostenendo che suo cognato Guelfo, mio prozio, non avrebbe avuto difficoltà a rispondere.
 Ma torniamo a noi: cosa abbiamo in comune? Avete indovinato: il cappello.
Ma torniamo a noi: cosa abbiamo in comune? Avete indovinato: il cappello.
Che non è simile, è proprio quello, il suo.
Trattasi infatti di un magnifico Borsalino, oggetto quasi di lusso, di quelli che non mi sarei mai comprato: è del tipo che non mi voglio permettere.
E' morbido, non foderato, si può schiacciare e strapazzare e con due carezze torna miracolosamente a posto.
Questo è appena un po' incencicato perché appallottolato in un cassetto c'è rimasto per più di trent'anni. Ce l'ho ritrovato mentre smontavo la casa della mia zia Baby, che era sua nipote, e si doveva trasferire in casa di riposo.
Come faccio a volte con i pantaloni alla zuava da roccia del povero Marco, mio cognato, che ogni tanto tiro fuori dall'armadio per fargli fare una giratina in montagna, a volte mi viene la voglia di indossarlo e di portarlo in giro.
Quando mi riesce di trovare i biglietti per la Scala, dove è stato di casa quasi tutte le sere per tanti anni, non lo dimentico mai.
Se
guardate con attenzione le foto allegate scoprirete, come nella
Settimana Enigmistica, che hanno in comune un particolare, nemmeno
tanto piccolo. Per darvi tempo di individuarlo vi dirò chi sono i
personaggi: quello che non sono io è Giulio Confalonieri, nella foto
con il soprano Carolina Segrera. Era un grande musicista e
musicofilo, famoso critico musicale. Fu autore di un libro, Barboni
a Milano,
che a suo tempo gli diede notorietà e successo, nonché soprattutto
di una eccellente storia della musica.
Si sussurra che sia stato l'autore della famigerata domanda sul controfagotto a lascia o raddoppia, che fece versare inchiostro a fiumi sui giornali dell'epoca, e che si difendesse dalle accuse di eccessiva difficoltà sostenendo che suo cognato Guelfo, mio prozio, non avrebbe avuto difficoltà a rispondere.
 Ma torniamo a noi: cosa abbiamo in comune? Avete indovinato: il cappello.
Ma torniamo a noi: cosa abbiamo in comune? Avete indovinato: il cappello.Che non è simile, è proprio quello, il suo.
Trattasi infatti di un magnifico Borsalino, oggetto quasi di lusso, di quelli che non mi sarei mai comprato: è del tipo che non mi voglio permettere.
E' morbido, non foderato, si può schiacciare e strapazzare e con due carezze torna miracolosamente a posto.
Questo è appena un po' incencicato perché appallottolato in un cassetto c'è rimasto per più di trent'anni. Ce l'ho ritrovato mentre smontavo la casa della mia zia Baby, che era sua nipote, e si doveva trasferire in casa di riposo.
Come faccio a volte con i pantaloni alla zuava da roccia del povero Marco, mio cognato, che ogni tanto tiro fuori dall'armadio per fargli fare una giratina in montagna, a volte mi viene la voglia di indossarlo e di portarlo in giro.
Quando mi riesce di trovare i biglietti per la Scala, dove è stato di casa quasi tutte le sere per tanti anni, non lo dimentico mai.
martedì 12 febbraio 2013
Londra e la signora Thatcher
di giorgio casera
La visita a Monza di Antonio Caprarica su invito di Novaluna per la presentazione del suo ultimo libro (Ci vorrebbe una Thatcher, sottinteso per l’Italia) mi ha ricordato una lontana esperienza.
Nel 1978 ero stato spedito dalla mia azienda a Londra per partecipare ad un progetto internazionale. Poiché la durata del progetto era di sei mesi avevo il diritto di portare con me la famiglia, cosa che feci senz’altro: sarebbe stata un’esperienza irripetibile. D’altronde i benefits applicabili in quella circostanza prevedevano il rimborso dell’affitto di una abitazione adeguata e del noleggio di un’auto.
Ealing
Presi dunque casa (il pianterreno di una bella villetta, con annesso giardino (curato e bellissimo), ad Ealing, quartiere della parte occidentale di Londra, non lontano da Greenford (a NO del centro), dove aveva sede il progetto. Potemmo così vivere, nel migliore periodo per Londra, da aprile a settembre, “immersi” nella società inglese (di fronte a casa c’era un campo di cricket, più inglese di così!). Vicini di casa e negozianti simpatici e cordiali (e non era raro incontrare qualche inglese che parlava un buon italiano). E poi, era eccitante vivere nella nazione di chi aveva rivoluzionato la musica leggera o la moda. Fummo subito colpiti da novità come le rotonde (round about) o i distributori di carburante automatici, in Italia ancora da venire.
L’ambiente di lavoro, formato da colleghi provenienti da tutta Europa, naturalmente con forte presenza di britannici, era molto stimolante, l’assistenza logistica agli europei del Continente molto curata.
Kensington e Hyde Park
Rientrati in Italia abbiamo ricordato a lungo le magnifiche domeniche trascorse nei parchi di Londra interrotte dalle visite ai bellissimi musei della città o ai mercatini di Charing Cross o lungo la Bayswater Road o al grande giardino zoologico (i miei figli avevano allora 5 e 3 anni). Ci pensavo anche mentre parlava Caprarica in libreria, con una punta di nostalgia.
National Gallery
Il periodo di grazia che stavamo vivendo non ci aveva impedito di notare certe situazioni, certi contrasti. L’Inghilterra non se la passava troppo bene. I miei colleghi inglesi erano i più “poveri” d’Europa: lo si notava dallo stile di vita, molto sobrio, dall’abbigliamento e… dall’attenzione alle spese (e non erano tutti scozzesi!). Il dott. Abelson, a cui mi ero rivolto per l’assistenza medica familiare, mi aveva parlato amaramente della crisi del Servizio Sanitario Nazionale (per quanto quando ne ebbi bisogno lo trovai inappuntabile!). La filiale inglese della multinazionale (una delle quattro “major” in Europa, le altre erano Germania, Francia ed Italia) arrancava di fronte ad una crisi economica generale e alla concorrenza di una società nazionale. Tant’é che per ospitare il progetto era stata presa in affitto una vecchia caserma dei pompieri, con ambienti molto spartani. Inoltre nei nostri viaggi domenicali da Ealing al centro di Londra, non potevamo fare a meno di notare qua e là zone sottoposte a degrado, sia pure ancora con segni di un passato splendore.
Il Prime Minister in carica era Callaghan, un laburista proveniente, credo, dal mondo sindacale, e non molto amato, con mia sorpresa, dai miei colleghi inglesi. In precedenza un’alternanza laburisti – conservatori (Wilson, Heath) che probabilmente non aveva saputo applicare una strategia che permettesse alla nazione di competere con gli altri Paesi industrializzati. Nel periodo londinese avevamo un’insegnante di inglese, Barbara, una ragazza neozelandese che si pagava così gli studi a Londra. Restammo in corrispondenza per qualche mese dopo il nostro rientro a Monza e ricordo le sue lettere nell’inverno ’78-’79 in cui ci raccontava di attraversare l’inverno più triste della sua vita (scioperi continui nei servizi pubblici, un senso di malinconia sui visi delle persone, incertezza sul futuro).
Callaghan non concluse la legislatura, dopo tre anni indisse nuove elezioni. E nell’aprile 1979 arrivò il ciclone Thatcher.
La visita a Monza di Antonio Caprarica su invito di Novaluna per la presentazione del suo ultimo libro (Ci vorrebbe una Thatcher, sottinteso per l’Italia) mi ha ricordato una lontana esperienza.
Nel 1978 ero stato spedito dalla mia azienda a Londra per partecipare ad un progetto internazionale. Poiché la durata del progetto era di sei mesi avevo il diritto di portare con me la famiglia, cosa che feci senz’altro: sarebbe stata un’esperienza irripetibile. D’altronde i benefits applicabili in quella circostanza prevedevano il rimborso dell’affitto di una abitazione adeguata e del noleggio di un’auto.
L’ambiente di lavoro, formato da colleghi provenienti da tutta Europa, naturalmente con forte presenza di britannici, era molto stimolante, l’assistenza logistica agli europei del Continente molto curata.
Il Prime Minister in carica era Callaghan, un laburista proveniente, credo, dal mondo sindacale, e non molto amato, con mia sorpresa, dai miei colleghi inglesi. In precedenza un’alternanza laburisti – conservatori (Wilson, Heath) che probabilmente non aveva saputo applicare una strategia che permettesse alla nazione di competere con gli altri Paesi industrializzati. Nel periodo londinese avevamo un’insegnante di inglese, Barbara, una ragazza neozelandese che si pagava così gli studi a Londra. Restammo in corrispondenza per qualche mese dopo il nostro rientro a Monza e ricordo le sue lettere nell’inverno ’78-’79 in cui ci raccontava di attraversare l’inverno più triste della sua vita (scioperi continui nei servizi pubblici, un senso di malinconia sui visi delle persone, incertezza sul futuro).
Callaghan non concluse la legislatura, dopo tre anni indisse nuove elezioni. E nell’aprile 1979 arrivò il ciclone Thatcher.
Iscriviti a:
Post (Atom)














































